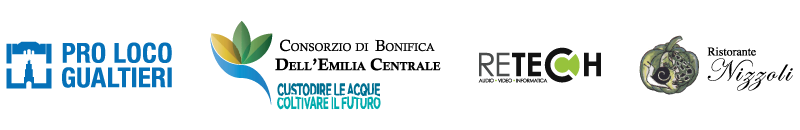Recensione: “In controluce a 200 decibel”
Deflagra, portandosi dietro il tempo, lo spazio e il suono. Come un caleidoscopio elettrico dove le luci pulsano e saturano lo spettro visivo, le grida quello uditivo, le storie quello cognitivo, deflagra lasciando dietro di sé solo macerie. Si presenta così Duecento decibel, un’idea drammaturgica coraggiosa che cerca di mettere in scena gli orrori della Guerra (che trascende luoghi ed epoche) anche attraverso l’occhio dello spettatore, ormai insensibile all’infinita sequenza frammentata propinataci dalla televisione. I tre allievi di Matutateatro autori dello spettacolo sono: Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e Andrea Zaccheo, protagonisti in scena, registi e in parte autori delle musiche (curate con l’appoggio di Riccardo Romano). La stratificazione del testo rappresenta fedelmente l’asistematicità dello sguardo nei confronti dei tragici eventi che accadono in paesi molto vicini al nostro, uno spettacolo che vuole sedimentarsi e lo fa, ma nella sua saturazione mostra dei difetti che spiccano in mezzo al fluire febbrile degli eventi. In Duecento decibel tra le altre cose ci sono i potenti del mondo, rappresentati come clown che “giocano alla guerra”, ci sono i nostri genitori che guardano la TV e si stufano di vedere tutte le atrocità di questo mondo «proprio mentre è ora di mangiare», ci sono le testimonianze reali, edulcorate per fini drammatici, e infine c’è persino lo spettatore, rappresentato a turno da uno dei tre interpreti che sedendosi fra il pubblico ogni tanto si stizzisce: «E cambia!» e come in un compulsivo skipping televisivo ci troviamo di fronte a un nuovo show di indifferenza quotidiana. L’alternarsi spiraleggiante delle storie e degli eventi però dialogano fra di loro, nell’apparente frammentazione c’è un trait d’union che costituisce il fulcro dello spettacolo, più che stimolare il «mea culpa» vuole assolvere un’urgenza dei tre autori. Se già tutto questo affastellarsi di elementi non bastasse i tre registi/attori hanno zeppato il testo di citazioni (perlopiù cinematografiche) e rimandi musicali un po’ troppo sentiti nelle ultime stagioni teatrali (penso in particolare a Everybody Needs Somebody to Love, pezzo soul del ’64 di Solomon Burke, ex-predicatore epigono di Roy Hamilton, resa celebre nel film-cult di John Landis The Blues Brothers). L’uso di pezzi musicali molto conosciuti, rielaborati nelle liriche e riarrangiati, serve per rompere il ritmo e provocare divertendo laddove non c’è niente da ridere, al tempo stesso però abbassa le aspettative del pubblico, appianando le pretese liriche. Non stupisce dunque se nelle musiche originali si creano i migliori ambienti sonori, semplici e sicuramente ingenui ma capaci di cogliere con grande sensibilità toni di un’inquietante asetticità, a metà tra il ritmo alienato di Cliff Martinez e le eleganti armonie di Jonny Greenwood. Quello che non convince in questo spettacolo è il suo barcamenarsi tra registri alti e bassi con una recitazione che, in particolare nella voce, non trova una dimensione pienamente espressiva. Il testo, quando frammentato, trova degli echi che all’interno della messa in scena crescono e assumono senso compiuto, quando invece si crea lo spazio per dei monologhi questi annullano la tensione drammatica e s’incartano in una narrazione-reportage asettica. Sebbene questo sia voluto e si fondi su un’idea solida, ovvero: staccare la spina al delirio caleidoscopio per far risaltare le voci dei testimoni, qui Alfonsi, Balestri e Zaccheo non paiono trovarsi con la solita scioltezza che li compete. L’uso dell’amplificazione invece è proprio fine a se stesso, quando poteva essere un utile strumento per sperimentare con i toni, i timbri e le estensioni. Gli attori giocano con i tre microfoni, delle volte mimando un canto, altre sfruttandoli come elementi scenici. Un elemento ricorrente che si svolge con una certa coerenza è la luce, ovvero quella parte di storia demandata all’interpretazione della Alfonsi. Il suo personaggio è una fotoreporter che resta affascinata da bambina dalla capacità peculiare della luce di mettere in chiaro le cose, così si ritrova a perseguirla in guerra come fotoreporter, e infine perdendone la prospettiva salvifica dopo aver subito un terribile stupro di gruppo. La luce così colpisce lo spettatore, lo irretisce addirittura, sfruttando controluci faticosi da affrontare ma necessari. Se dunque il ritmo forsennato della pièce sembra ben impiantato sull’idea di far esplodere una bomba nelle prossimità del pubblico, andando «oltre la soglia del dolore» e mostrando la sterilizzazione emotiva provocata dai media nel nostro quotidiano (mentre al tempo stesso un altro quotidiano, di inimmaginabile terrore, avviene proprio accanto a noi), permane l’idea che si potesse osare ancora di più per quanto riguarda l’espressività della voce. In sintesi Matutateatro vola in alto, rischia e si presenta a “Direction under 30” mostrando i muscoli, cedendo però il passo sulla sperimentazione attoriale, giocata su toni miti e rockeggianti, non del tutto in linea con la forza propulsiva che soggiace alla deflagrazione iniziale. Quello che invece più convince è la narrazione per “bassa risoluzione”, citando Massimo Mantellini, che mostra una realtà difficile se non impossibile da mappare perché decostruita in mille frammenti lasciati scorrere nella marea dell’informazione spettacolarizzata, esplosa, deflagrata.
Giuseppe Di Lorenzo
Visto al Teatro Sociale di Gualtieri il 20.07.2018