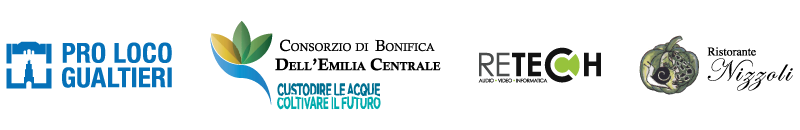Quell’aria più vitale
A Gualtieri ci torniamo ogni anno. Veniamo un po’ da tutta Italia, e il numero degli affezionati cresce man mano che il festival fa nuove conquiste. Ci piace trovarci là in luglio; abbiamo preso questo gusto per la bassa reggiana d’estate, per la penombra del teatro che regolarmente ci inghiotte e poi ci risputa alla grande piazza deserta; per tutti i caffè, gli scambi di opinioni fitti e continui e quel misto di lambrusco e Autan che ci accompagna di sera in sera.
E non è mica solo questione di un festival.
Diciamo che il Teatro Sociale si predispone all’attaccamento: ci spalanca davanti tutta una costellazione di organizzatori sorridenti, spettatori di lungo corso, artisti affezionati, ristoratori e baristi che sarebbero già da soli personaggi sufficienti a popolare i suoi muri di mattoni scoperti, i palchetti affrescati ancora segnati dalle piene del Po, il palcoscenico esploso e ribaltato al contrario.
Qualcosa di felliniano?
Inoltre ci sono un ostello costruito su barconi, fluttuante all’occorrenza; la riva di un fiume su cui casomai vedere sorgere il sole; biciclette per spostarsi da un paese all’altro; cene a base di zucca e lumache; una festa conclusiva con esiti ogni anno diversi. Un pianoforte minuscolo, da Schroeder, e un intero repertorio di canzoni e di gesti che si consolida di volta in volta.
Insomma, il contesto è una sfida al gioco mitopoietico. Non si lascia Gualtieri senza una piccola rinnovata mitologia di posti e di parole.
Ma più in profondità c’è qualcosa di quell’aria più vitale che è davvero contagiosa, per dirla con Gaber. C’è che ci apparteniamo, al festival, perché sentiamo subito che in qualche modo il festival ci appartiene a sua volta, ci ascolta, cresce con noi. Siamo stati noi, qualche settimana fa, a scegliere sei dei tanti spettacoli proposti. Siamo noi quei cerchi di persone che si formano spontaneamente tra uno spettacolo e l’altro, noi che avviamo, attraverso una serie di dibattiti, una digestione collettiva degli spettacoli visti.
Ci chiediamo come spartirci il tempo e le parole. Ci confrontiamo, non ci assomigliamo ma ci contaminiamo, ci mettiamo in discussione a vicenda. Siamo un fazzoletto di pubblico eterogeneo, analitico, ma tenace e caloroso. E poi, ovviamente, giovane.
La condizione di questa partecipazione è stabilita in modo lapidario già dal nome: trent’anni al massimo, non di più. Una chiamata ai giovanissimi, un “mutuo soccorso teatrale” per trovarsi, determinarsi e formarsi in semi-autonomia.
Ci contiamo: siamo ventiquattro spettatori. Ci affiancano sette critici. In mezzo a noi ci sono attori, registi, tecnici di sei compagnie.
Questi sei spettacoli sono una piccola educazione all’ascolto, all’elasticità, all’indagine. L’occhio si adatta al passaggio dalle luci colorate e dallo spietato vigore comunicativo con cui Ortika dipinge la depressione al buio in cui Dispensa Barzotti dissemina pezzetti di un racconto muto sulla senilità. Dal candore astratto che contraddistingue la prigionìa di Duramadre alla clownerie nera, macabra, isterica dell’Otello di Gilda Antistanti. Dalla luce ambrata della Puglia onirica, dolceamara di Lumen al mondo digitale, a campiture piatte, del videogioco di Bahamut. Ce ne sarebbe da discutere per giorni e giorni.
Invece i giorni sono solo tre, e una piccola parte spetta a un confronto esterno, con attori, registi, critici un po’ più grandi e molto più rodati di noi (prima Grabriele Vacis a Reggio; ora Oscar De Summa, Arianna Scommegna, Simone Nebbia a Guastalla). In questi dialoghi quotidiani raccogliamo racconti interessanti, ma una delle nostre attività principali mi sembra quella di incassare domande: che ci aspettiamo dal festival, ad esempio. Che ci facciamo lì. Chi siamo.
E sono domande giuste. Che ci faccio qui, in effetti? Bisogna che cominci a rispondermi da subito: il primo giorno De Summa ci dice che il teatro dev’essere per noi l’occasione di cercare la nostra identità e i nostri spazi malgrado tutto. Per noi, ghettizzati da una produzione culturale gerontomane? Noi, intrappolati in un teatro che occupa sempre meno righe sui giornali e se la canta e se la suona da solo? Noi, generazione anemica, noi, nell’epoca dell’usa e getta, tutto e subito, una botta e via?
Ay, there’s the rub: forse siamo qui per per rieducarci all’esistenza come generazione, e sbarazzarci di questa autocommiserazione che non ci esaurisce mai del tutto. Non sarebbe mica poco. Cominciare da qui, dal renderci conto di chi siamo. Dove siamo. Dove vogliamo andare. Quanto siamo disposti a partecipare. È strano poi questo pellegrinaggio: in più di cinquanta, dalle metropoli a un punto sperduto nella bassa reggiana che è quasi equidistante da tre città e vicino a nessuna. Mentre ci penso direi quasi che la risposta è già contenuta in questo movimento.
Crederesti che non c’è nulla, e invece c’è una concentrazione che non trovo a Milano. Ci sono un silenzio e una ricchezza di spazio…
Com’è bella la provincia a cui è imposto un marchio di marginalità, sulla cui identità si dibatte altrove. Piena di vitalità inaspettata: come assomiglia alla nostra generazione. Benissimo. Noi, è qui che guardandoci ci riconosciamo.